di Francesco Ricci
Per chi non la ricerchi, per chi non la desideri, la solitudine in estate può risultare insopportabile. Le giornate lunghe, il bel tempo, le cene all’aperto, le domeniche sconfinate: tutto, ma proprio tutto, pare essere un invito al divertimento, al piacere, alla compagnia. E in effetti per la maggior parte delle persone è così. Poi verrà l’autunno, poi verrà l’inverno, gli usci saranno serrati, le finestre richiuse, il freddo e la pioggia renderanno amiche le ore trascorse tra le pareti domestiche, che le luci artificiali inizieranno a rischiarare già a metà pomeriggio. Ma finché è estate, finché il tempo è bello, è una gioia stare all’aperto, fare amicizia, intrecciare parole e intrecciare destini, stando seduti al tavolino di un caffè in una piazza di paese e di città o all’ombra di un porticato. Ci sono uomini, però, che paiono condannati fin dalla nascita a essere soli. Per carattere o per sorte. Spesso a causa dell’uno e dell’altra. Per loro l’estate è una stagione terribile. Il lettore che abbia un po’ di familiarità con quelle vere e proprie short stories che sono le poesie di Lavorare stanca (1936) di Cesare Pavese, comprende subito a cosa mi stia riferendo. Già la lirica eponima, infatti, mette in scena un uomo che percorre le strade e le piazze cittadine senza scambiare una sola parola con nessuno, senza trovare il coraggio, in particolare, per fermare una donna che magari, con un po’ di fortuna, potrebbe diventare un giorno la sua sposa, la sua compagna di vita. La solitudine del paesaggio urbano (“le piazze son vuote”, “Le piazze e le strade / son vuote”, “Nella piazza deserta”, “la piazza ritorna deserta”, “sulla piazza deserta”) diviene il correlativo oggettivo perfetto sia della solitudine del personaggio (“quest’uomo”) che è al centro di questa poesia-racconto (la definizione risale allo stesso Pavese) sia di quella dell’io lirico – “l’io visibile dell’autore” come lo definisce Marziano Guglielminetti – che emerge in primo piano con l’interrogativa “Val la pena esser solo, per essere sempre più solo?”. D’altra parte, in quasi tutti i testi che compongono Lavorare stanca la città (Torino) è costantemente rappresentata, in contrapposizione alla campagna, come il luogo dell’alienazione e della solitudine, specie nel dopocena e di notte, quando a popolarla restano le prostitute, gli ubriachi, i suonatori di chitarra, i frequentatori di osterie. Gli anni delle chiassose sere contadine, fatte di giochi, di rincorse, di amici, sono anni lontani.
Traversare una strada per scappare di casa
lo fa solo un ragazzo, ma quest’uomo che gira
tutto il giorno le strade, non è più un ragazzo
e non scappa di casa.
Ci sono d’estate
pomeriggi che fino le piazze son vuote, distese
sotto il sole che sta per calare, e quest’uomo, che giunge
per un viale di inutili piante, si ferma.
Val la pena esser solo, per essere sempre più solo?
Solamente girarle, le piazze e le strade
sono vuote. Bisogna fermare una donna
e parlarle e deciderla a vivere insieme.
Altrimenti, uno parla da solo. È per questo che a volte
c’è lo sbronzo notturno che attacca discorsi,
e racconta i progetti di tutta la vita.
Non è certo attendendo nella piazza deserta
che s’incontra qualcuno, ma chi gira le strade
si sofferma ogni tanto. Se fossero in due,
anche andando per strada, la casa sarebbe
dove c’è quella donna e varrebbe la pena.
Nella notte la piazza ritorna deserta
e quest’uomo, che passa, non vede le case
tra le inutili luci, non leva più gli occhi:
sente solo il selciato, che han fatto altri uomini
dalle mani indurite, come sono le sue.
Non è giusto restare sulla piazza deserta.
Ci sarà certamente quella donna per strada
che, pregata, vorrebbe dar mano alla casa.
(Cesare Pavese, Lavorare stanca)
(31 luglio 2019)



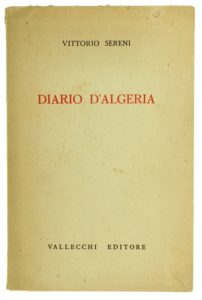
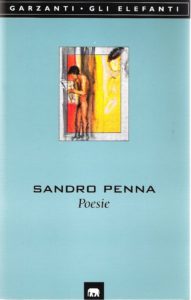


Be First to Comment